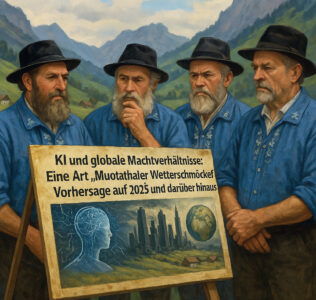L’iperdigitalizzazione e l’iperautomazione sono processi che stanno cambiando radicalmente il nostro modo di lavorare, vivere e interagire. Questa trasformazione di vasta portata non si basa solo su singoli progressi tecnologici, ma su una complessa interazione di diversi componenti chiave. Per dare forma a questo cambiamento sono necessari almeno cinque elementi essenziali: chip, energia, dati, talento e modelli di intelligenza artificiale.

I chip sono il cuore di ogni applicazione digitale. Processori e GPU ad alte prestazioni consentono di elaborare grandi quantità di dati e modelli di IA in tempo reale. Le aziende investono sempre più nello sviluppo e nell’ottimizzazione di questo hardware per migliorare l’efficienza e la velocità dei loro sistemi. Un esempio è la collaborazione tra start-up e aziende tecnologiche affermate per sviluppare soluzioni innovative e sempre più ottimizzate dal punto di vista dell’efficienza e portarle sul mercato.
L’energia è un altro fattore critico. I sistemi digitali e soprattutto i modelli di intelligenza artificiale richiedono enormi quantità di elettricità per eseguire i loro complessi calcoli. Si stima che il solo ChatGPT, ad esempio, richieda ogni giorno il consumo di elettricità di circa 35.000 famiglie statunitensi, il che corrisponde a circa 1 GWh.
È quindi fondamentale utilizzare fonti energetiche sostenibili ed efficienti per minimizzare l’impatto ambientale e ridurre i costi operativi a favore della redditività del bilancio complessivo.
I dati sono la materia prima (“miniera d’oro nel proprio giardino”) della trasformazione digitale. I modelli non possono essere addestrati e utilizzati in modo efficace senza set di dati completi e di alta qualità, il più possibile strutturati e contestualizzati. Le aziende devono garantire che i loro dati siano corretti, adeguati al contesto, aggiornati e ben strutturati. La protezione e la sicurezza dei dati rivestono un ruolo centrale per ottenere la fiducia degli utenti e soddisfare i requisiti di legge.
Il talento è la forza trainante di ogni iniziativa digitale di successo. Sono indispensabili specialisti con conoscenze approfondite in settori quali le applicazioni AI con il giusto set di strumenti, l’ingegneria aziendale, la scienza dei dati, l’apprendimento automatico e lo sviluppo di software. Le aziende devono investire nella formazione e nello sviluppo dei propri dipendenti per promuovere le competenze e le conoscenze necessarie. Programmi come il Champions Programme e le certificazioni in aree come “low coding” / “no coding” / “automazione” possono contribuire ad ampliare le competenze dei dipendenti e ad aumentare la loro motivazione in una mentalità riallineata per l’intera organizzazione.
I modelli di intelligenza artificiale sono, per così dire, gli “strumenti” o le pale digitali / i motori a vapore / i motori che guidano l’iperdigitalizzazione. Permettono di riconoscere modelli a volte irriconosciuti in grandi quantità di dati, di mappare un passato più completo, di supportare previsioni ottimizzate e di ottimizzare e persino automatizzare basi decisionali estese. Le aziende devono assicurarsi che gli strumenti di IA utilizzati o addirittura i propri modelli di IA siano sicuri, robusti, trasparenti ed etici. L’integrazione dei modelli di IA nei processi aziendali può portare a un significativo aumento dell’efficienza e dell’innovazione.
Non solo “fish and chips”
In sintesi, chip, energia, dati, talenti e modelli di intelligenza artificiale sono i cinque pilastri su cui si basa il futuro dell’iperdigitalizzazione. Le aziende che utilizzano questi componenti in modo efficace e li collegano e orchestrano in modo intelligente saranno in grado di sviluppare soluzioni innovative, prendere decisioni migliori, aumentare la loro competitività e, in ultima analisi, ottimizzare la loro “vicinanza al cliente digitale”.
Eppure / per fortuna: se si vuole padroneggiare il mondo digitale e quello “reale”, bisogna prima comprenderlo “realmente”
L’ulteriore sviluppo dell’intelligenza artificiale (IA) verso l’Intelligenza Generale Artificiale (AGI) è un processo tanto affascinante quanto impegnativo. In linea di principio, l’AGI mira a creare un’intelligenza artificiale in grado di svolgere qualsiasi compito intellettuale in modo autonomo e persino migliore/più efficiente di quanto possa fare un essere umano. Il modo per raggiungere questo obiettivo richiede l’integrazione estesa e l’ulteriore sviluppo di varie tecnologie come la robotica, la sensoristica, l’aptica e la computer vision, che forniscono all’IA i relativi sensi estesi come la vista, l’udito, l’olfatto, il gusto, il tatto, l’equilibrio e persino il senso di profondità nell’esperienza del proprio corpo e della propria vita.
Si tratta di molto più di una possibile analogia con “Se non vuoi sentire, devi sentire”: l’IA è da tempo in grado di sentirci o leggerci (ad esempio tutta la nostra conoscenza del mondo), ma sta ancora imparando a toccare e vedere – sia attraverso la computer vision, i sensori aptici, la robotica o i modelli multimodali che tentano non solo di interpretare il mondo, ma anche di comprenderlo contestualmente e reagire ad esso in modo significativo.
La tecnologia dei sensori in generale e la robotica in particolare svolgono un ruolo centrale nell’interazione fisica dei sistemi di intelligenza artificiale con il mondo reale. I progressi della robotica consentono alle macchine di svolgere compiti complessi che prima erano riservati agli esseri umani. I sensori e l’aptica sono fondamentali per dare alle macchine una migliore comprensione del loro ambiente e la capacità di interagire in modo sensibile. La computer vision consente ai sistemi di intelligenza artificiale di interpretare e reagire alle informazioni visive, un aspetto cruciale per molte applicazioni.
Queste tecnologie sono attualmente in fase di rapido sviluppo e stanno guidando la prossima fase evolutiva dell’IA. Uno dei principali motori di questo sviluppo è, ad esempio, il cosiddetto “effetto Sputnik di DeepSeek dalla Cina” a metà gennaio 2025, che descrive l’improvvisa e intensa ondata di innovazione innescata da progressi tecnologici rivoluzionari. Gli approcci rivoluzionari di DeepSeek alla ricerca e all’applicazione dell’IA, alcuni dei quali sono stati successivamente relativizzati, hanno suscitato scalpore in tutto il mondo e alimentato ulteriormente la competizione per la supremazia nella tecnologia dell’IA.
Salti quantici e informatica quantistica
L’ulteriore combinazione di queste tecnologie e i relativi progressi fino a veri e propri “salti quantici” (anche l’informatica quantistica ci aspetta dietro l’angolo, armata di più di un “bastone”…) ci avvicina alla cosiddetta singolarità – il punto in cui i sistemi di IA possono superare l’intelligenza umana e, soprattutto, continuare a svilupparsi in modo indipendente. Questo sviluppo porta con sé sia enormi opportunità sia sfide che devono essere superate o addirittura adeguatamente regolate.
Non dobbiamo preoccuparci dell’ulteriore sviluppo della tecnologia e dell’IA in particolare, ma dei suoi utilizzatori (compresi gli Stati, la criminalità informatica, il terrorismo, la disinformazione), che usano questa tecnologia e la usano anche specificamente contro persone e organizzazioni.
Il “kill switch”: da una battuta di fantascienza a un vero problema di sicurezza?
Un altro aspetto interessante di questo sviluppo è il cosiddetto “kill switch”, uno spegnimento di emergenza per i sistemi di intelligenza artificiale che finora è stato spesso trattato come una gag o una battuta di fantascienza. Tuttavia, con il progresso verso sistemi autonomi e di autoapprendimento, in particolare in relazione all’informatica quantistica e alla possibile singolarità, un “kill switch” a livello hardware o software potrebbe effettivamente diventare una misura di sicurezza necessaria.
Mentre i modelli di IA di oggi sono ancora chiaramente controllabili, i sistemi futuri che si svilupperanno in modo autonomo potrebbero essere più difficili da prevedere o regolare. Un “ingegnere del kill switch”, ovvero un ruolo/meccanismo specializzato per l’implementazione di tali meccanismi di spegnimento basati su regole o eventi, potrebbe assumere una funzione essenziale nella ricerca sulla sicurezza dell’IA, paragonabile ai sistemi di failsafe/failback nelle centrali nucleari o nei sistemi di controllo degli aerei.
Resta da vedere se il “kill switch” sarà in definitiva solo una misura di rassicurazione psicologica o uno strumento di controllo necessario.
Tuttavia, è molto probabile che il problema diventi una nuova specializzazione nella direzione di un cosiddetto “Junkware Removal Engineer” JRE come parte della gestione della qualità. Con una nuova competenza specializzata nell’identificazione, ottimizzazione o rimozione di codice e funzioni indesiderate o pericolose in app, codice, prompt, automazioni e agenti in termini di sicurezza e conformità. Ciò è dovuto in particolare al numero crescente di power user che co-sviluppano tali funzioni utilizzando approcci “no code” / “low code”, inizialmente senza conoscenze approfondite di programmazione ed esperienza in materia di protezione dei dati, sicurezza dei dati e requisiti di conformità nell’ambito della gestione del rischio ICT.
Fridel Rickenbacher è ex co-fondatore, co-CEO, partner, membro del Consiglio di Amministrazione e ora “imprenditore in azienda” / “consulente senior” presso Swiss IT Security AG / Swiss IT Security Group. A livello federale, è rappresentato come esperto e attore in “Digital Dialog Switzerland” + “National Strategy for the Protection of Switzerland against Cyber Risks NCS”. Nella sua missione “sh@re to evolve”, è attivo da anni come membro editoriale, attivista di gruppi di esperti e associazioni, ad esempio presso SwissICT, swissinformatics.org, isss.ch, isaca.ch, bauen-digital.ch nei settori della digitalizzazione, dell’ingegneria, delle nuvole, dell’architettura ICT, della sicurezza, della privacy, della protezione dei dati, dell’audit, della compliance, del controlling, dell’etica dell’informazione, nelle relative consultazioni legislative e anche nell’istruzione e nella formazione (CAS, diploma federale).
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta nel aprile 2025 sulla rivista Schwyzer Gewerbe e viene qui riprodotto con il permesso dell’autore.
Photo: AI generated.